
Il pezzo che vi apprestate a leggere ruota intorno a tre cardini fondamentali: Bob Dylan, il suo più recente disco di inediti Rough and Rowdy Ways e Alessandro Carrera. Il professore della University of Houston, nonché traduttore ufficiale in Italia per Feltrinelli degli scritti del premio Nobel per la letteratura 2016, non è soltanto un cattedratico con la passione per Dylan, ma lui stesso uomo di lettere e note. Note musicali intendo, considerato il suo passato da cantautore diventato memoria per l’impegno didattico negli States, anche se di tanto in tanto torna a suonare in varie università americane dove lo chiamano per tenere incontri e lezioni sulla folk music e la canzone italiana.
Recentemente Carrera ha registrato le canzoni scritte in questi anni, e una scelta è apparsa, con traduzione inglese a fianco, in un libro appena uscito in America (le canzoni si possono ascoltare sul sito della casa editrice: https://www.gradivapublications.com/latest-news).
Ci sarà occasione per parlarne, qui sotto le sue riflessioni sull’ultimo disco di Dylan che gran plauso ha ricevuto un po’ in tutto il mondo (vendite comprese) e “dentro cui” i dylanologi hanno iniziato a scavare per estrarre le gemme oscure per capire meglio l’opera dell’autore e le sue considerazioni sui tempi e sull’essere umano.
 Qual è stata la sua reazione al primo ascolto di Rough and Rowdy Ways?
Qual è stata la sua reazione al primo ascolto di Rough and Rowdy Ways?
«Ho pensato che Dylan avesse finalmente trovato la nuova incarnazione del suono “sottile, selvatico, come mercurio” che ha sempre cercato dopo Blonde on Blonde. L’aveva ritrovato anche in altri dischi recenti, soprattutto in “Love and Theft” e in Tempest, ma è un suono che si può perdere in fretta ed è liquido come il mercurio. Qui invece è coerente dall’inizio alla fine. Anche quando l’arrangiamento è minimo, quel suono c’è.»
Ne La Voce di Bob Dylan lei scrive che le canzoni di Dylan sono sequenze di sogni in cui molti sensi convivono anche se incompatibili e dei quali l’autore non ha più di noi la chiave per decifrarli. Ritiene che questa lettura si possa applicare anche alle dieci canzoni che compongono quest’ultimo disco? 
«Sì, perché ci sono molti versi che acquistano senso solo se sono considerati come parte di un testo più ampio, che è poi l’intero disco. Del resto, Dylan crea delle macro-canzoni almeno fin da Time Out of Mind. Quello che non si capisce in una canzone acquista senso nella canzone successiva o in quella precedente. Oppure bisogna arrendersi al fatto che alcuni testi procedono per libera associazione, e che non ogni significante troverà un preciso significato. Un esempio è Key West (Philosopher Pirate). Con questo non voglio dire che il testo non abbia senso; tutt’altro. È solo che spesso Dylan sceglie coscientemente di non scegliere quello che gli si presenta alla mente, e si affida all’inconscio, che crea legami magari tenui tra un’immagine e l’altra ma in fin dei conti non sbaglia mai. Solo che ci vuole più tempo a coglierli.»
Qualche anno fa, durante la presentazione dei tre volumi aggiornati delle Lyrics, lei disse che è quasi impossibile stabilire se Dylan abbia veramente coscienza di ciò che sta creando o se invece non sia un medium di qualcosa che passa attraverso di lui. Dopo quest’ultima opera conferma o corregge il suo pensiero?

«Non posso che confermare. Ma bisogna intendersi. Un artista sa quello che fa. Non sa come lo fa. E poiché non sa il come, non può nemmeno razionalizzarlo a posteriori. Dylan poi è un artista che non vuole dominare la propria ispirazione, anzi vuole che sia la sua ispirazione a dominarlo. La teoria dell’artista come medium di forze più grandi di lui, o di lei, è molto antica, ancora più antica dello Ione di Platone, dove viene esplicitata. In tempi moderni è stata ripresa, tra gli altri, da T.S. Eliot. Negli ultimi anni Dylan si è avvicinato molto alla letteratura classica, le citazioni dei classici sono aumentate molto nelle canzoni da Modern Times in qua, ed ecco che in Rough and Rowdy Ways troviamo infatti Mother of Muses che è la conferma di quanto appena detto: un’invocazione a Mnemosyne, la Memoria che è madre della poesia, e in seconda istanza a Calliope, musa della poesia epica. Come a dire: rendimi un puro messaggero di ciò che tu vuoi farmi dire.»
Nel corso della carriera il metodo compositivo di Dylan ha affrontato numerose mutazioni. Nelle ultime due decadi si è divertito a forgiare puzzle letterari e musicali anche attraverso arditi incastri di citazioni. Pensa che Rough and Rowdy Ways mantenga questa tendenza in toto o analizzando la struttura poetica e sonora del disco ci si imbatte in qualcosa di diverso?
«La mantiene, anzi la radicalizza. L’ha sempre fatto, anche nei primi dischi, ma ora è diventato il suo modus operandi principale. Fa venire in mente quello che lui stesso avrebbe detto a Joni Mitchell una volta, e che ho sentito ripetere da lei in un’intervista. Non è lui che scrive le canzoni, è “the box”. Ogni volta che trova un verso o una frase interessante lo scrive e lo mette in una scatola, poi prende una manciata di foglietti, li mette insieme e tira fuori una canzone. Be’, è chiaro che si tratta di un’esagerazione, ma
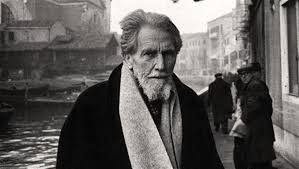
qualcosa di vero c’è. È anche un’estensione del cut-up usato da William Burroughs: prendere pezzi di articoli di giornali e riviste e inserirli così, senza spiegazione, in un altro contesto. Dylan non fa proprio questo, più che un cut-up lo chiamerei piuttosto un paste-up, un incollare più che un tagliare, e sicuramente c’è un lavoro di selezione del materiale, che deve anche essere messo in strofe e in rima, e deve avere una sua coerenza canzone per canzone. Ma d’altra parte parecchi poeti modernisti hanno scritto (anche) così, attraverso una scelta di citazioni, da Ezra Pound a John Ashbery.»
Sin dagli esordi uno dei tratti più presenti nell’epica di Dylan è rappresentata dal peso dell’Apocalisse sul genere umano. Anche nella sua ultima intervista al New York Times l’autore torna sull’argomento affermando che la pandemia che sta sconvolgendo il pianeta può essere la vigilia di uno sconvolgimento definitivo dell’umanità. Cosa trova nel disco di questa suo particolare profilo?
«Oh, gli americani sono ossessionati dall’Apocalisse, sulla quale io la penso come D.H. Lawrence, che ci ha scritto un bellissimo saggio. È popular religion, piena di desiderio di vendetta e punizione, molto lontana dalla sofisticazione del messaggio del Vangelo e inclusa nel Nuovo Testamento, dove c’entra fino a un certo punto, soprattutto perché si credeva che l’avesse scritta lo stesso autore del Vangelo di Giovanni. Gli americani hanno creato un mostro medievale (è il loro medioevo, che non hanno mai  avuto) esaltando l’Apocalisse più dei Vangeli, ma con questa scelta ci convivono da quattrocento anni e bisogna prenderla per quello che è. Dylan ne è un prodotto. Devo dire che ogni tanto mi stufo a sentirgli predire la fine del mondo, visto che lo fa dal 1962. Certamente, Dylan predica il “tempo della fine”, non tanto “la fine dei tempi” cioè un modo di vivere che è sempre all’erta, sempre aperto alla possibilità di una rivelazione definitiva, però in questo non sempre si solleva al di sopra del senso comune del suo paese, come invece ha saputo fare in molte altre occasioni. Ci riesce, benissimo, in A Hard Rain’s A-Gonna Fall come anche in Ain’t Talkin’. Altre volte non fa che prendere la minestra dell’Apocalisse e riscaldarla, ma non in quest’ultimo disco, dove il sarcasmo, l’ironia e l’imprevedibilità prendono spesso il sopravvento.»
avuto) esaltando l’Apocalisse più dei Vangeli, ma con questa scelta ci convivono da quattrocento anni e bisogna prenderla per quello che è. Dylan ne è un prodotto. Devo dire che ogni tanto mi stufo a sentirgli predire la fine del mondo, visto che lo fa dal 1962. Certamente, Dylan predica il “tempo della fine”, non tanto “la fine dei tempi” cioè un modo di vivere che è sempre all’erta, sempre aperto alla possibilità di una rivelazione definitiva, però in questo non sempre si solleva al di sopra del senso comune del suo paese, come invece ha saputo fare in molte altre occasioni. Ci riesce, benissimo, in A Hard Rain’s A-Gonna Fall come anche in Ain’t Talkin’. Altre volte non fa che prendere la minestra dell’Apocalisse e riscaldarla, ma non in quest’ultimo disco, dove il sarcasmo, l’ironia e l’imprevedibilità prendono spesso il sopravvento.»
«Dopo aver licenziato Tempest, Dylan affermò che non gli era venuto come lo aveva pensato perché nelle intenzioni si era ripromesso di comporre qualcosa di più religioso. Otto anni dopo, quanto c’è di religioso in Rough and Rowdy Ways?
«Rough and Rowdy Ways aspira all’epica, non alla poesia religiosa. Probabilmente il disco di inni religiosi che Dylan aveva in mente è ancora di là da venire. Questo non vuol dire che la religione non ci sia, ma è nascosta sotto il manto dell’allegoria o per meglio dire della “figura”. In Murder Most Foul ci sono riferimenti sottili e altri meno sottili a Gesù Cristo. Non arrivo a dire che Dylan “in realtà” sta parlando di Cristo facendo credere che stia parlando di Kennedy, che dunque funzionerebbe come pura figura Christi. Questa sarebbe un’interpretazione superficiale. Sta parlando di Kennedy, ovviamente, ma prende elementi dalla passione di Cristo perché sono l’archetipo, il codice di riferimento del sacrificio.»
Musicalmente il disco è anch’esso un matrimonio tra più forme sonore. Non siamo di fronte a un inedito, questa volta colpisce però un  maggiore amalgama tra abbellimenti, struttura armonica e melodia tanto che, per fare un esempio due canzoni in successione nella tracklist come My Own Version of You e I’ve Made My Mind to Give Myself to You suonano come un tutt’uno. È d’accordo?
maggiore amalgama tra abbellimenti, struttura armonica e melodia tanto che, per fare un esempio due canzoni in successione nella tracklist come My Own Version of You e I’ve Made My Mind to Give Myself to You suonano come un tutt’uno. È d’accordo?
«Sì, il disco è più curato negli arrangiamenti, anche quando sono scarni, e molto omogeneo. Dylan ci ha dedicato più attenzione di quanto non avesse fatto, per dire, con Modern Times, che è un disco molto bello per la qualità di varie canzoni, ma suona come una prova, non come un prodotto finito. In Rough and Rowdy Ways il fatto che alcune canzoni siano simili tra loro non disturba affatto.»
Il passaggio o momento musicale che più l’ha coinvolta?
«L’attacco di Key West è magico, con quella delicatissima figurazione della chitarra che si vorrebbe non finisse mai. Ma ci sono sorprese anche in canzoni apparentemente semplici. Mother of Muses ha una melodia che in due tratti si sospende su due accordi, la prima volta su un mi minore, la seconda su un re maggiore, che invece di passare alla risoluzione in la maggiore indugiano per mezzo verso. Sembra una cosa da niente ma quell’esitazione dà il tono all’intera canzone. E Black Rider ancora di più. Ci sono cambiamenti impercettibili in ogni strofa. Potrebbero essere improvvisati, pensati, o una mescolanza delle due cose, ma rendono Black Rider, a mio parere, la canzone più interessante dell’intero album. Peccato che Dylan abbia voluto infilarci un verso che è un vero schiaffo, quel “the  size of your cock will get you nowhere” che a mio parere stona non poco. È vero, è un verso di Giovenale, ripreso dalla Satira IX, e Giovenale è un poeta che non le manda a dire (è citato anche in Tempest), ma questa non è una giustificazione. Black Rider è una canzone amara, anche violenta nei confronti di un personaggio misterioso, che è contemporaneamente saggio, esperto e malvagio (in genere il “black rider” è il diavolo, e i riferimenti vanno dal Franco cacciatore di Carl Maria von Weber alla rivisitazione rock di Tom Waits), ma quel riferimento alle dimensioni del suo membro a me sembra del tutto gratuito. Voglio dire, in Giovenale chi dice quella battuta è Naevolus, un “battone” scaricato dal suo cliente in favore di qualcuno più dotato di lui. Naevolus si rivolge mentalmente al nuovo favorito e dice la battuta che sappiamo. Intende dire che gli attributi non contano niente rispetto al destino, ed è forse questo che Dylan intendeva suggerire, ma c’era modo e modo di dirlo. Se qualcuno riesce a dimostrarmi che invece Dylan ha fatto benissimo a inserire quel verso, lo starò ad ascoltare.»
size of your cock will get you nowhere” che a mio parere stona non poco. È vero, è un verso di Giovenale, ripreso dalla Satira IX, e Giovenale è un poeta che non le manda a dire (è citato anche in Tempest), ma questa non è una giustificazione. Black Rider è una canzone amara, anche violenta nei confronti di un personaggio misterioso, che è contemporaneamente saggio, esperto e malvagio (in genere il “black rider” è il diavolo, e i riferimenti vanno dal Franco cacciatore di Carl Maria von Weber alla rivisitazione rock di Tom Waits), ma quel riferimento alle dimensioni del suo membro a me sembra del tutto gratuito. Voglio dire, in Giovenale chi dice quella battuta è Naevolus, un “battone” scaricato dal suo cliente in favore di qualcuno più dotato di lui. Naevolus si rivolge mentalmente al nuovo favorito e dice la battuta che sappiamo. Intende dire che gli attributi non contano niente rispetto al destino, ed è forse questo che Dylan intendeva suggerire, ma c’era modo e modo di dirlo. Se qualcuno riesce a dimostrarmi che invece Dylan ha fatto benissimo a inserire quel verso, lo starò ad ascoltare.»
Guardando indietro, sempre dal punto di vista sonoro, a quale suo album lo possiamo avvicinare?
«Agli album più recenti, dedicati alla canzone americana classica e al repertorio di Sinatra, dove magari la voce non è sempre adatta al materiale, ma sono arrangiati molto bene e con molta cura. È la stessa cura che troviamo in Rough and Rowdy Ways. Non è musica da concerto, è musica da camera. Avrei voluto sentire la stessa cura in Modern Times.»
E della voce, giunta al 79° anno d’età, che dice?
«Con una battuta, potrei dire che non è peggio di quanto non sia mai stata in precedenza, ma in realtà è la voce migliore da parecchio tempo in qua. Dylan si è disfatto di quel tono miagolante che assumeva a volte negli anni Ottanta e Novanta, e anche dell’ostinazione a cantare tutto nello stesso modo, come se fosse sempre la stessa canzone, in molti concerti tra il 2000 e il 2010. La voce è molto più morbida, più malleabile, per quanto le limitazioni dell’età siano innegabili. Aver lavorato sulla canzone americana classica gli è servito.»
Se potesse riassumere il disco in una strofa o in un verso, dove cadrebbe la sua scelta?
 «Su un verso di Mother of Muses: “I’ve already outlived my life by far”, che tradurrei con “Alla mia vita sono già sopravvissuto”. È un verso commovente, sincero, e anche paradossale (qualcuno mi ha detto che anche questa è una citazione, anche se indiretta, ma non so da dove e comunque qui ci sta bene), perché è collocato in un contesto in cui Dylan chiede a Mnemosyne di “forgiare l’uomo che lui è”, come se dovesse prepararlo alla vita; come se Dylan insomma fosse un giovane poeta che chiede aiuto alla Musa per il lavoro che deve ancora compiere.»
«Su un verso di Mother of Muses: “I’ve already outlived my life by far”, che tradurrei con “Alla mia vita sono già sopravvissuto”. È un verso commovente, sincero, e anche paradossale (qualcuno mi ha detto che anche questa è una citazione, anche se indiretta, ma non so da dove e comunque qui ci sta bene), perché è collocato in un contesto in cui Dylan chiede a Mnemosyne di “forgiare l’uomo che lui è”, come se dovesse prepararlo alla vita; come se Dylan insomma fosse un giovane poeta che chiede aiuto alla Musa per il lavoro che deve ancora compiere.»
Key West (Philosopher Pirate) si appresta a diventare il nuovo tormentone tra i dylanologi. Chi vi vede un’aria ironica dell’autore che trasforma un luogo da turismo di massa come potrebbe essere Riccione a paradiso in terra, chi invece la Itaca di questo tempo, chi ancora sostiene che l’autore, a dispetto di quello che appare a prima vista, a Key West non sia ancora arrivato mentre un’altra “scuola di pensiero” ritiene che egli stia scrivendo proprio da laggiù. Che cosa racchiude per lei questa canzone?
 «Non lo so ancora, perché appunto ci vorrà tempo per decifrarla. Key West mi appare come un luogo reale, anche turistico (alcuni dei versi sono proprio indicazioni per turisti, anche se imprecise), ma allo stesso tempo mitico, uno di quei paradisi perduti o meglio, “soglie” dove gli opposti s’incontrano. Le Highlands scozzesi dell’omonima canzone, insomma, ma anche luoghi ambigui come Desolation Row o Scarlet Town. La canzone comincia buttandoci nel mezzo dell’azione, senza preparazione alcuna, con il Presidente McKinley in agonia (l’altro presidente ucciso, oltre a Kennedy e a Lincoln), e sta a noi trovare i collegamenti tra McKinley, Key West e tutto il resto. Che ci sono; i dylanologi hanno già cominciato a scoprirli, ma sarà arduo metterli assieme (ad esempio il ruolo di McKinley e di Key West come luogo strategico nella guerra ispano-americana, anche se non si capisce come da lì si salti a Radio Luxembourg, o meglio, sì, si può capire, ma bisogna stiracchiare parecchio l’argomento). In alcune canzoni Dylan ha creato storie parallele, che s’incontrano solo in qualche angolo remoto dell’universo. Ad esempio, Goodbye Jimmy Reed è una canzone su Jimmy Reed, ma è anche rivolta a Van Morrison, che è un estimatore di Jimmy Reed, con alcuni precisi riferimenti all’Irlanda del Nord (il termine
«Non lo so ancora, perché appunto ci vorrà tempo per decifrarla. Key West mi appare come un luogo reale, anche turistico (alcuni dei versi sono proprio indicazioni per turisti, anche se imprecise), ma allo stesso tempo mitico, uno di quei paradisi perduti o meglio, “soglie” dove gli opposti s’incontrano. Le Highlands scozzesi dell’omonima canzone, insomma, ma anche luoghi ambigui come Desolation Row o Scarlet Town. La canzone comincia buttandoci nel mezzo dell’azione, senza preparazione alcuna, con il Presidente McKinley in agonia (l’altro presidente ucciso, oltre a Kennedy e a Lincoln), e sta a noi trovare i collegamenti tra McKinley, Key West e tutto il resto. Che ci sono; i dylanologi hanno già cominciato a scoprirli, ma sarà arduo metterli assieme (ad esempio il ruolo di McKinley e di Key West come luogo strategico nella guerra ispano-americana, anche se non si capisce come da lì si salti a Radio Luxembourg, o meglio, sì, si può capire, ma bisogna stiracchiare parecchio l’argomento). In alcune canzoni Dylan ha creato storie parallele, che s’incontrano solo in qualche angolo remoto dell’universo. Ad esempio, Goodbye Jimmy Reed è una canzone su Jimmy Reed, ma è anche rivolta a Van Morrison, che è un estimatore di Jimmy Reed, con alcuni precisi riferimenti all’Irlanda del Nord (il termine  “proddy”, che compare nella canzone e che sta per Protestante, si usa solo lì). Poi c’è l’elemento profetico, trattato seriamente in False Prophet e ironicamente in Key West. La strofa in cui il narratore dice che a dodici anni gli hanno fatto sposare una prostituta, ma quella non è la fine della storia, perché “lei è ancora carina, e siamo ancora amici” mi fa ridere ogni volta che la sento (lì la voce è impareggiabile), ma chi nella Bibbia è costretto a sposare una donna di dubbia reputazione è il profeta Osea. Va’ a capire…»
“proddy”, che compare nella canzone e che sta per Protestante, si usa solo lì). Poi c’è l’elemento profetico, trattato seriamente in False Prophet e ironicamente in Key West. La strofa in cui il narratore dice che a dodici anni gli hanno fatto sposare una prostituta, ma quella non è la fine della storia, perché “lei è ancora carina, e siamo ancora amici” mi fa ridere ogni volta che la sento (lì la voce è impareggiabile), ma chi nella Bibbia è costretto a sposare una donna di dubbia reputazione è il profeta Osea. Va’ a capire…»
Un altro must narrativo dylaniano viene confermato: il movimento, il cammino, tanto per tornare indietro quanto per avvicinarsi verso una non ben definita meta. A ben leggere i versi però ci troviamo davanti più volte a una visione amara sia nei confronti della sua stessa esperienza umana sia dell’occhio verso l’umanità tutta. Dylan è un artista che non ha mai spacciato conforto da quattro soldi ma qui siamo davanti a un disorientamento, uno spaesamento piuttosto acuto.
«Lo sguardo disincantato sull’esperienza umana corrisponde a quello che Henry Miller sosteneva essere la missione dell’artista: inoculare il mondo con la propria disillusione, come un vaccino, insomma, che difende da entusiasmi troppo facili. L’essenziale è non cadere nel cinismo gratuito, e mi sembra che Dylan non ci sia mai caduto. Lo spaesamento è quello dei nostri tempi, e Dylan lo interpreta, ma in canzoni come Mother of Muses e anche in Key West, tutto sommato, sembra indicare che la via dell’integrità personale è ancora possibile, e augurabile.»
Un paio di volte l’autore si lascia a espressioni come “You know what I mean / You know exactly what I mean” (My Own Version of You) e “You know what I’m talking about” (Mother of Muses) come a voler evidenziare che lui non fa altro che sottolineare una realtà assodata se non proprio un’ovvietà che l’interlocutore, sia esso uomo o divinità, non può permettersi di non capire. Cosa nasconde secondo lei la necessità di includere interiezioni come queste?
 «Sono estremamente comuni nell’inglese parlato, più o meno come “cioè” in italiano, e servono ad allentare la tensione, ma anche a evitare di sentenziare troppo, visto che si dà credito all’interlocutore di sapere già su che terreno siamo. Mi viene in mente di quando Paul McCartney ha raccontato come lui e John Lennon hanno composto She Was Standing There. McCartney pensa di cominciare con “She was just seventeen / Of the school she was queen” o qualcosa del genere. Lennon storce il naso e propone: “She was just seventeen / You know what I mean”, che è molto meglio.»
«Sono estremamente comuni nell’inglese parlato, più o meno come “cioè” in italiano, e servono ad allentare la tensione, ma anche a evitare di sentenziare troppo, visto che si dà credito all’interlocutore di sapere già su che terreno siamo. Mi viene in mente di quando Paul McCartney ha raccontato come lui e John Lennon hanno composto She Was Standing There. McCartney pensa di cominciare con “She was just seventeen / Of the school she was queen” o qualcosa del genere. Lennon storce il naso e propone: “She was just seventeen / You know what I mean”, che è molto meglio.»
In Crossing the Rubicon, a un certo punto Dylan si chiede: “How can I redeem the time – the time so idly spent”. Redimere il tempo. Il solo porsi questa domanda lascia spiazzati non trova?
«Redimere il tempo è quello che fa l’arte, e soprattutto l’arte di chi ha vissuto abbastanza a lungo da voltarsi indietro e constatare che ha perso tempo, che se si fosse impegnato di più avrebbe fatto più arte. Dylan di tempo ne ha perso veramente poco, data la sua mole di lavoro, ma il vero artista rimpiangerà sempre di non aver fatto ancora di più, di non essere andato più a fondo.»
Un ruolo tutto suo è giocato da Murder Most Foul e non solo per la specifica collocazione all’interno dell’album, sia nel cd sia nella versione in vinile. Non dico sia un capitolo a sé stante, ma l’originalità della scrittura di questo pezzo non può passare sotto traccia.
«Però in un certo senso è davvero un capitolo a sé stante. Se Dylan avesse  fatto uscire solo Murder Most Foul tutti avrebbero pensato che una canzone di quel peso poteva stare da sola. E se Rough and Rowdy Ways fosse uscito senza quell’ultima canzone, nessuno penserebbe che dopo Key West manca ancora qualcosa. Ma, visto che Dylan ha deciso di metterle assieme, abbiamo a un tempo due album diversi e un album doppio. Chiaramente Murder Most Foul è la conclusione “nobile” del ciclo, ma invece di una conclusione epica (come suggerirebbe il già confessato amore del poeta per Calliope, la musa dell’epica) abbiamo una conclusione elegiaca, qui nel senso di “lamento funebre” che è anche esortazione: il ripetuto “play” rivolto al disc-jockey, suonami questo, suonami quello, sembra proprio l’invito al flautista (il flauto era lo strumento dell’elegia) a suonare questa o quella melodia durante la cerimonia funebre o il successivo banchetto. Del resto, epica ed elegia non si possono sempre distinguere.»
fatto uscire solo Murder Most Foul tutti avrebbero pensato che una canzone di quel peso poteva stare da sola. E se Rough and Rowdy Ways fosse uscito senza quell’ultima canzone, nessuno penserebbe che dopo Key West manca ancora qualcosa. Ma, visto che Dylan ha deciso di metterle assieme, abbiamo a un tempo due album diversi e un album doppio. Chiaramente Murder Most Foul è la conclusione “nobile” del ciclo, ma invece di una conclusione epica (come suggerirebbe il già confessato amore del poeta per Calliope, la musa dell’epica) abbiamo una conclusione elegiaca, qui nel senso di “lamento funebre” che è anche esortazione: il ripetuto “play” rivolto al disc-jockey, suonami questo, suonami quello, sembra proprio l’invito al flautista (il flauto era lo strumento dell’elegia) a suonare questa o quella melodia durante la cerimonia funebre o il successivo banchetto. Del resto, epica ed elegia non si possono sempre distinguere.»
Secondo lei quale immagine del tempo interiore sta vivendo oggi Dylan alla luce di quest’ultima opera?
«Non credo sia diversa da ciò che è sempre stata almeno a partire da Blood On the Tracks, se non da prima. Il critico inglese Christopher Ricks ha scritto che il titolo di No Time to Think, una delle canzoni di Street Legal (1978) va inteso in due modi: “non c’è tempo per pensare” oppure” c’è il non-tempo da pensare”. Dylan costruisce canzoni come affreschi narrativi, in cui però l’antecedente, il fatto presente e le sue conseguenze occupano lo stesso  spazio, devono essere colti dall’occhio e dall’orecchio in un tutto unico, come se al loro interno il tempo non passasse, o fosse tutto concentrato in un “quanto”, una “durata” non riducibile a un tempo cronologico. L’esempio più calzante è Tangled Up in Blue, che ho analizzato a lungo nel mio libro La voce di Bob Dylan, nell’edizione del 2011, ma vale anche per Key West o Murder Most Foul. Chissà, magari le canzoni di Dylan sarebbero piaciute ad Einstein; sono dei vortici gravitazionali che distorcono il tempo e lo spazio… Meglio fermarsi qui prima di dire ulteriori sciocchezze.»
spazio, devono essere colti dall’occhio e dall’orecchio in un tutto unico, come se al loro interno il tempo non passasse, o fosse tutto concentrato in un “quanto”, una “durata” non riducibile a un tempo cronologico. L’esempio più calzante è Tangled Up in Blue, che ho analizzato a lungo nel mio libro La voce di Bob Dylan, nell’edizione del 2011, ma vale anche per Key West o Murder Most Foul. Chissà, magari le canzoni di Dylan sarebbero piaciute ad Einstein; sono dei vortici gravitazionali che distorcono il tempo e lo spazio… Meglio fermarsi qui prima di dire ulteriori sciocchezze.»
Bella intervista che rileggerò con calma, buone feste!
Grazie Enri, buone feste anche a te e a tutti i tuoi cari.